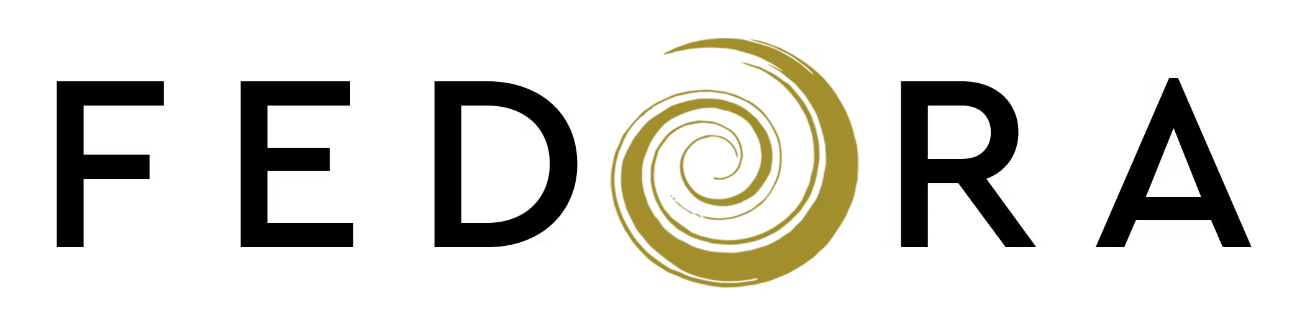Prendere coscienza del dolore e del suo regno
Inanna e Ereshkigal erano due divinità sumere. La prima era conosciuta come la dea della terra e del cielo, della fertilità, della bellezza e dell’amore . La seconda, sua sorella, come la dea dell’oscurità, legata al mondo degli inferi, del sotterraneo, dei sentimenti profondi e scuri. Il mito racconto che Inanna sia voluta andare a trovare la sorella addolorata per la perdita del marito e che, dopo essere passata per 7 cancelli che le hanno richiesto di spogliarsi dei suoi orpelli, abbia incontrato la furia della sorella Ereshkigal che, anziché accoglierla ed essere grata della sua visita, in preda ai suoi scuri sentimenti, la appese per i piedi e la lasciò dissanguarsi. E così Inanna restò per 3 giorni e 3 notti perché il percorso di Inanna era quello di prendere coscienza della morte e confrontarsi con il dolore perché solo così poteva curare le ferite e solo così poteva rinascere.
Lo sappiamo in tante forme e modi diversi. Il ciclo mestruale femminile ci fa sperimentare mese per mese la morte e la nascita continua, l’andamento ciclico del nostro percorso. Sentiamo parlare o leggiamo di Vita/Morte/Vita e siamo spesso invitate ad accogliere la morte nelle sue diverse forme. Lo facciamo, accettiamo che quel qualcosa muoia e viviamo il dolore di quella morte in quel momento.
A volte ci sfugge che il dolore è un vero e proprio regno oscuro, profondo…di cui non si conoscono i confini e le limitazioni. Il dolore ci fa paura perché sappiamo quando ci entriamo, ma non sappiamo mai quando finiamo di attraversarlo e talvolta è come una lunga catena che fa rimbalzare di anello in anello senza sapere quanto lunga possa essere quella catena. Il dolore è un regno…molto più esteso di quello che in quel momento stiamo vivendo. Ci sembra un dolore immenso a volte…per un episodio “piccolo”…perché? Proprio perché quel dolore è l’anello di una catena che porta ancora altrove. In una ferita…in più ferite..profonde e dimenticate che sanguinano ancora o sono infettate. E nel sangue che sgorga, nel pus che geme…non ci vogliamo stare. La riconosciamo quella ferita e sentiamo di esserci stati già tante volte lì con lei, ci sembra di averla curata e spazientite le diciamo “dai ora basta! Andiamo avanti!” perché ci sembra anche di autocommiserarci o di piantarci nel ruolo della vittima a vita. E allora smettiamo di seguire la catena nel buio, la luce di sopra ci spinge a reagire, a volerci più bene e questo ci allontana e ci nutre insieme…ci allontana dal nocciolo del dolore da sciogliere, ma ci nutre della luce che serve ad illuminare quel buio profondo. Perché servono entrambe. Perché arriverà quel momento in cui avremo oltrepassato l’ultimo cancello e saremo lì di fronte a quella ferita, a quella morte che da tempo viviamo e di cui solo in quel momento potremo prendere coscienza. Potremo guardare quella sensazione di dolore e invece di stare in un’apnea che tenta di non cedere, manterremo lo sguardo in quella vaghezza, rilasceremo il respiro e…..! E non sarà comprendere solo la morte, la fine, vedere qualcosa che non c’è, sarà lasciare andare e dire è dolore e morte, senza tempo, senza luogo, paradossalmente, senza dolore. Sarà un buio non confuso, amico, non più vago in cui la ferita smette di sanguinare e la cicatrice filtra luce. E in qualche modo mollare la presa e sentire l’emozione che fluisce, gli occhi che si puliscono, le parole che scorrono, il cuore che vibra.